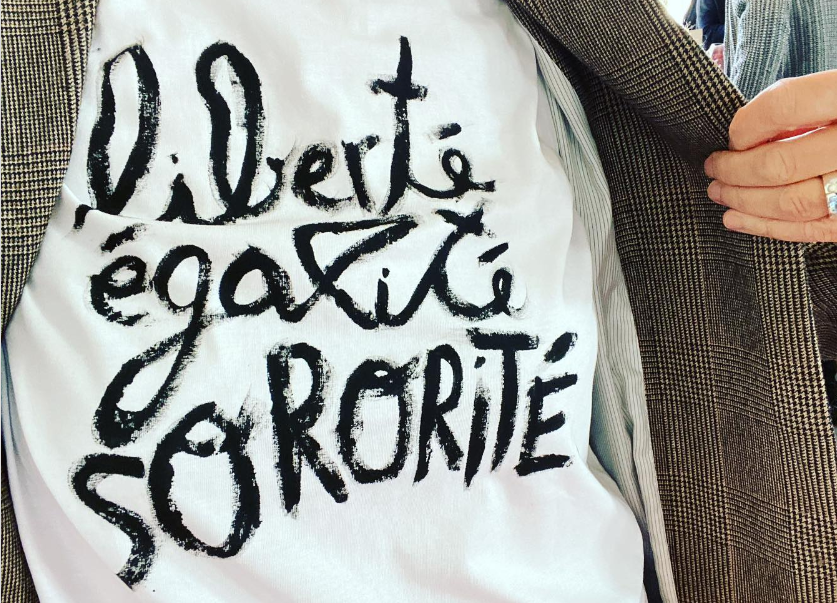Musicista sinfonica ed esploratrice del regno fungino, Camilla Mazzanti con Fungotropia racconta la forza gentile della curiosità: cambiare prospettiva, accettare l’incertezza, intrecciare relazioni come un micelio tra natura e suono
Due anime che si parlano: natura e musica. Tra boschi e partiture, Camilla Mazzanti, fungarola e musicista, coltiva un diario d’apprendimento che trasforma la paura in permesso creativo e la curiosità in comunità. L’abbiamo incontrata sul principiare dell’autunno, quando il suo progetto – Fungotropia, una newsletter dove i funghi diventano una lente per guardare il mondo “dal basso verso l’alto” – compie un anno. Uno sguardo, il suo, che ci insegna a immaginare più in grande. La sua, è la quarta storia di Talea, il progetto editoriale di Vite Storie di Vino e di Donne che raccoglie storie belle per rifiorire.
Camilla Mazzanti è una violinista della Filarmonica Toscanini di Parma. Ed è una grande appassionata di funghi. L’ascolto allenato in orchestra, per lei, si traduce nel bosco in attenzione al dettaglio, ai ritmi lenti, alle relazioni invisibili. Dedizione, disciplina e relazione, elementi centrali nella musica, ritornano anche nell’osservazione dei funghi: il micelio come partitura nascosta, l’osservazione come esercizio quotidiano. E così anche l’immaginario sonoro si apre, con le tante voci che Camilla raccoglie e ogni mese riporta nella sua newsletter. Due mondi che non si sommano, ma si fecondano a vicenda. “In fondo” ci dice, “anche la musica nasce dallo stesso impulso della vita fungina: il desiderio umano di celebrare la propria presenza e di esprimere la propria relazione con ciò che lo circonda.”
La curiosità come una bussola per orientarsi nel bosco come nella vita
Tutto ha inizio dopo il Covid, con un ritorno alla natura che per Camilla diventa una pratica quotidiana di cura e di consapevolezza di sé: le sue passeggiate nel bosco diventano veri e propri rituali, dove anche guardare il succedersi delle stagioni affina il senso dei tempi lunghi, del ciclo vita-decomposizione-rigenerazione che i funghi incarnano. “Mi sono accorta che è stupendo poter ammirare il susseguirsi delle stagioni e ho scelto di non farne mai più a meno”. Vive ancora in città, ma ha allenato lo sguardo ai piccoli segni che la natura porta sempre con sè: un profumo, un colore, un fungo che fa capolino al fianco di un albero. A guidarla, la sua curiosità. Un’attitudine che la spinge a uscire, osservare, fare domande e a collegare i funghi a geografie, culture e biografie: “Nel mio zaino da esploratrice la curiosità non manca mai”. Così un incontro casuale nel sottobosco si trasforma in traccia, confronto e apprendimento continuo, alimentando una mappa sempre più ricca di conoscenza e di relazione. “Lo smartphone è il mio taccuino visivo, ma anche uno strumento di condivisione con chi è più esperto di me e a cui chiedo pareri e confronti”.
La paura di “non essere all’altezza”, il permesso creativo e la forza della condivisione: come nasce Fungotropia
In questi giorni, Camilla festeggia il primo compleanno di Fungotropia, la newsletter che ha iniziato a scrivere per tracciare connessioni tra il mondo dei funghi e il nostro mondo. “Non è solo una tappa importante o un brindisi da ricordare: è la prova che la curiosità, resa pratica e condivisa, può generare comunità. Un brindisi che celebra il coraggio di iniziare, l’umiltà di imparare e la gioia di una comunità che cresce come un bosco”. Per arrivare a pubblicare il primo episodio, il percorso non è stato facile. Come spesso accade, anche per lei il sentirsi non all’altezza è stato una soglia da attraversare. “Mi chiedevo: ma chi sono io per parlare di funghi?”. Ma per lei condividere è far circolare idee capaci di generare altre idee. E supera questa paura che la blocca, pensando a cosa farebbe se fosse un fungo. “Ho pensato al micelio, che è ciò da cui un fungo nasce, cresce, si nutre e comunica con gli altri funghi. Il micelio cresce sempre per contatto e diventa scambio, reciprocità”.
I funghi appaiono e scompaiono, costringono a sospendere il controllo e a coltivare presenza, pazienza, meraviglia
Così, decide di aprire uno spazio diverso, e tutto suo: una newsletter-diario per imparare insieme al suo pubblico, senza cattedra, accogliendo il processo e l’errore. “Mi sono concessa la possibilità di utilizzare Fungotropia come progetto creativo, un diario di appunti di qualcuno che sta imparando e che vuole condividere con altre persone che, magari, sono su un percorso simile e sono curiose di scoprire”. La paura non scompare, ma viene incanalata e così attiva relazioni nutrienti. Uscire dai confini della propria formazione non è facile, ma Camilla riesce pian piano a creare un ecosistema intergenerazionale e appassionato tra fungaioli, micologi, artisti, autori. O semplici persone curiose come lei. Gli scambi online prolungano il bosco nello spazio digitale e fanno emergere connessioni inedite. Il risultato è un capitale relazionale che alimenta tanto il progetto quanto le persone che ne fanno parte. Proprio come un fungo con il suo micelio!

Cambiare prospettiva: guardare in basso per immaginare in grande
La prossima volta che vi troverete a camminare in un bosco, fateci caso. Di solito, tendiamo a guardare verso l’alto, per cercare la luce e il cielo tra gli alberi. Non certo sotto ai sassi o tra le radici (a meno che non stiate andando proprio per funghi!). L’esercizio di curiosità che propone Camilla è proprio quello di spostare lo sguardo, dalle cime al sottobosco, per immaginare cose diverse. La cosa più sorprendente è quella che lei, nel raccontarsi a Talea, chiama epistemologia dell’incertezza: “i funghi appaiono e scompaiono, costringono a sospendere il controllo e a coltivare presenza, pazienza, meraviglia”, dice Camilla. Questo ribaltamento di prospettiva diventa un allenamento creativo: imparare a vedere ciò che è marginale, umile, nascosto e farne una fonte di senso. “La sorpresa è parte del gioco e plasma uno sguardo più elastico”. I funghi sono un promemoria della transitorietà: fioriscono e svaniscono rapidamente, abitano il confine tra vita e deperimento, trasformano ciò che muore in nutrimento. Nel folklore europeo diventano messaggeri del tempo che scorre, tra incanto e inquietudine. “Sbucano all’improvviso, restano lì pochissimo e poi spariscono, come a ricordarci che nulla dura per sempre.” Questo sguardo aiuta a fare pace con il cambiamento: nulla è per sempre e proprio per questo ogni apparizione va accolta con gratitudine.